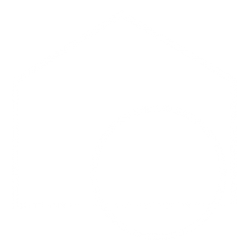L’insostenibile virus
Si sono spesi fiumi di parole sul “mondo che verrà” dopo l’esperienza del Coronavirus. E’ certamente presuntuoso intervenire ulteriormente, anche perché, fra gli fra gli architetti si è già svolta la consueta gara alla visibilità mediatica. Ma alcune questioni radicali emergono (la “produttività della crisi” oramai è un luogo comune ma ha solide fondamenta). Affidandoci alla forza sintetica delle immagini, quelle che rimarranno nella memoria collettiva non saranno (spero) quelle delle città vuote che molti hanno definite finalmente “belle“, insieme all’acqua pulita di Venezia o i cervi e caprioli in città: per molti rimarranno nel ricordo le impressionati immagini dei camion militari carichi di bare che, nella notte, si allontanano con discrezione – o, forse, “furtivamente” – dalle cittadine della bergamasca dove non era più possibile seppellire i cadaveri. Quelle immagini ci hanno destato, oltre che le considerazioni sul significato e sull’occultamento della morte nella nostra società edonistica, quelle più immediate riguardanti la condizione terribile della solitudine estrema nei momenti estremi, causata dal confinamento. Una solitudine che ha colpito non solo i singoli, i morti e le persone a loro vicine, ma è diventata, con un ossimoro, collettiva, cancellando il rito delle esequie, il momento del ricordo della e per la comunità, e di questa spazzando il fondamento stesso, la condizione di possibilità. Questo ci interessa come architetti, ostinati, oltre ogni evidenza, nel pensare l’architettura e la città come fatto collettivo e in questo cercarne le ragioni e significato. Come ci deve colpire un’altra immagine: quella della inquietante, perfetta coincidenza fra i rilevamenti satellitari (di massima presenza di particolato PM, eseguiti dall’ESA) e le aree dove più intensa e fatale è stata la pandemia. La discussione sulla sostenibilità ambientale è uscita rudemente dal mondo delle prospettive del reale (però, per i più, rimandato al futuro) possibile, per irrompere nel presente con la drammatica concretezza di quelle bare accatastate negli obitori. Le discussioni sul ruolo (e gli usi) dei territori e delle città sono riapparse prepotentemente, anche se sul da farsi le proposte sono state spesso discutibili: fuga dalla “città cattiva”, ritorno alla campagna, oppure lo spalmare un po’ di verde su terrazzi o giardini privati o fare più giardini pubblici e piste ciclabili (senza parlare delle illuminati affermazioni del tipo: è meglio restare chiusi in una casa grande che in una piccola…). Tutti, ora, sono convintamente “sostenibili”: in realtà il COVID-19, con la necessità di “confinamento” e “distanziamento” sembra spazzare via nell’immediato ogni ipotesi di città sostenibile, ed anche ogni ipotesi di abitare sostenibile. La città è il luogo delle relazioni: essa è strutturalmente antitetica all’isolamento. Anche alla scala dell’alloggio l’unica immediata e praticabile ipotesi (perché antica) di abitazione sostenibile (e che lentamente pareva essere oggetto di attenzione ) costituita dal co-housing (la con-divisione di parte dei servizi e luoghi dell’alloggio) è, improvvisamente, diventata un pericoloso esempio “di ciò che non ci deve assolutamente essere” e costituire l’opposto di ogni norma ed esortazione. Una fabbrica di virus. Ma non possiamo rinunciare alla città e non ci serve costruire ipotesi futuristiche sulla città nuova. Un modello accettabile, sostenibile ambientalmente e socialmente, esiste e noi fortunatamente e quotidianamente lo abbiamo sotto gli occhi: il centro storico della città europea, luogo e matrice della civiltà occidentale e espressione della nozione stessa di cittadinanza. Il territorio Italiano più di altri è costruito su tale antica struttura di piccoli e medi centri. La forza dell’invenzione dovrà essere applicata a tale modello morfologico e sociale alla sua straordinaria complessità. Non è questione semplice, ovviamente, e qui si vuole indicare unicamente una urgente necessità. E la forza dell’invenzione e della verifica dovrà applicarsi in primis sulla ricerca della giusta dimensione delle città e sul rapporto reciproco fra le parti entro una idea di possibile Stadtlandschaft, una città-paesaggio. Noi possiamo partire dal territorio che conosciamo con una grande operazione di mirata densificazione (e demolizione congiunta) che ripensi al rapporto storico fra città e paesaggio agricolo e naturale. L’eccezionalità del paesaggio Italiano è stata in passato proprio nella precisione e complementarietà fra sistemi costruiti e spazi aperti di scala paesaggistica. Ora dobbiamo infatti necessariamente procedere con uno sguardo opposto a quello che ci ha condotto alla disastrosa dissipazione attuale. Uno sguardo completamente ribaltato. Dobbiamo partire dai “vuoti” (la campagna, per alcuni definita la “natura”) per ridefinire margini, pause, vuoti, entro il costruito continuo attuale. Mi sembra più difficile e prioritario costruire i vuoti che le parti di città che da questi prenderanno la misura, definirne carattere e processi per ri-ottenerli, renderli sostenibili e attuabili anche economicamente. Perché questi vuoti, anche lasciati ad un nuova condizione di naturalità (questo chiedono anche le direttive europee su agricoltura e ambiente) saranno sempre più importanti in senso ecologico e sistemico. Indubbiamente ciò ha un sapore antico e non fa i conti con processi globali extra europei ma noi abbiamo e dobbiamo misuraci con le città antiche, spesso piccole, da cui ripartire e che ci viene chiesto di riabitare e non abbandonare. Questioni urgenti e di grande difficoltà per cui la cultura architettonica, persa fra virtuosismi formali che vorrebbero in realtà esorcizzare un futuro tanto declamato quanto temuto e sconsolate ritirate liriche individuali, sembra impreparata. Ma se ha una conseguenza positiva il COVID-19 ha condotto alla consapevolezza che la tecnologia non può tutto e che le chiusure e gli individualismi soccombono infine sempre. Abbiamo bisogno di più stato, di più condivisione e partecipazione democratica, dobbiamo pensare a programmi ampi e duraturi di sviluppo e uso delle risorse. Consapevoli che questo è semplicemente il contrario di quanto successo negli ultimi 30 anni. Di più collettività e non di meno, di più cittadinanza. La cittadinanza che mi sembra manifestarsi nell’ultima immagine forte apparsa sulla stampa e che ricorderò di questa pandemia: quella del Sindaco di Cervignano che accoglie e porta il saluto di una comunità ai camion con i feretri che, viaggiando di notte, sono giunti all’alba nella città friulana. Completamente solo, nel vasto piazzale, indossando la fascia tricolore. Raramente quel tricolore ha assunto un senso meno retorico e più concretamente alto.